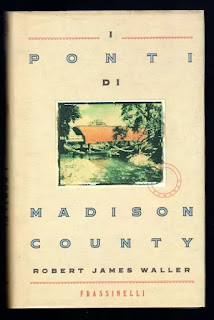Che poi proprio di “romanzo” non si tratta…
Comunque, tanto per cominciare, ecco due diversi riassunti della storia. Il primo è quello, poetico e sublimato, che compare sulla quarta di copertina della prima edizione per Frassinelli, il secondo invece è quello ironico e dissacrante di una simpatica blogger:
1)
2)
(https://libroperamico.blogspot.com/2017/03/recensione-180-i-ponti-di-madison.html)
Insomma, al di là di possibili rivisitazioni divertite e divertenti, una storia in sé davvero disarmante nella sua banalità: un fotografo giramondo incontra per caso, nel bel mezzo dell’America più profonda, una casalinga repressa e insoddisfatta; i due si amano appassionatamente per quattro giorni ma alla fine lei rinuncia a lui pensando ai propri doveri di moglie e di madre. Bon, fine della storia.
Una storia banale, ok, che però il film (1995) ha saputo magistralmente tradurre in immagini e atmosfere, ottenendo non a caso varie candidature agli Oscar e ai Golden Globe.
Ma qui
stiamo parlando del libro… «Una delle più belle storie d’amore della
letteratura», come ancora recita la quarta di copertina? Temo proprio che
Shakespeare e Tolstoj si stiano rivoltando nella tomba, ma anche solo Nicholas
Sparks non si sente tanto bene…
E qui voglio subito precisare una cosa: siccome il libro parla di un amore travolgente e impossibile, che resta vivo e indelebile nell’anima dei protagonisti per più di vent’anni, non si creda che io sia cinicamente insensibile a questo genere di storie. Conosco l’amore, quell’amore. Conosco la vertigine del perdersi nell’altro, l’impressione abbacinante di fondersi con l’universo. Conosco il ricordo incancellabile di un volto, di un odore. Conosco il rimpianto che dura una vita.
Ma qui, cavolo, la storia è proprio raccontata male!
Dunque, cominciamo dall’inizio. La storia viene presentata come una vicenda realmente accaduta che viene ricostruita a posteriori da uno scrittore-detective, cui i figli della protagonista si rivolgono perché appunto trasformi diari e appunti della madre in una narrazione vera e propria (anche se non si capisce a quale scopo). Quindi, saremmo in presenza di un narratore esterno che, in modo più o meno oggettivo, racconta una storia altrui.
La faccenda però si complica, perché lo scrittore-detective, a un certo punto del capitolo che funge da introduzione, dice: Alla fine del mio vagabondaggio, mentre mi dirigevo verso la Madison County, mi parve per molti versi di essere diventato Robert Kincaid. Dunque, una dichiarata identificazione tra narratore e personaggio.
Ma
non finisce qui, anzi, perché se si va a cercare qualche informazione
sull’autore del romanzo, Robert James Waller, si scopre che fu anche fotografo
e musicista dilettante, ovvero esattamente ciò che è Robert Kincaid, il
protagonista del romanzo. Per non parlare dell’omonimia Robert-Robert, ovvero
autore-protagonista, e delle loro evidentissime somiglianze fisiche (bretelle
arancioni comprese.) Insomma, abbiamo a che fare con un autore-narratore-personaggio
che sono in realtà la medesima persona.
Cosa determina tutto questo? Determina il fatto che non è mai chiaro “chi parla”: il narratore, in una narrazione più o meno oggettiva e spersonalizzata? Il protagonista, in una focalizzazione interna realizzata dal narratore? O piuttosto l’autore, che proietta e ricostruisce se stesso nel protagonista, in modo palesemente compiaciuto e autocelebrativo?
Complessa e complicata è anche la struttura narrativa: a un capitolo introduttivo in cui a parlare in prima persona è il narratore-detective, seguono due capitoli dedicati ognuno ai due protagonisti (Robert, Francesca), capitoli che però non sono affatto solo descrittivi ma anche narrativi, in quanto accolgono passaggi che fanno parte integrante e imprescindibile della storia. Addirittura, nel capitolo Francesca ci si sposta cronologicamente alla fine della storia, quando lui è già morto e lei, anni dopo, ripercorre nel ricordo il loro incontro. Seguono un paio di capitoli esclusivamente narrativi in cui viene raccontata la vicenda centrale (inframezzati però da testi poetici di non si sa chi…), per finire con lettere, deliranti abbozzi di racconti e, in ultimo, la trascrizione di un’intervista rilasciata al narratore-detective da un sassofonista jazz che avrebbe raccolto le ultime confidenze del protagonista.
Insomma, una struttura narrativa a dir poco caotica (anche se, ammetto, originale e accattivante).
Ma mi rendo conto che queste sono disquisizioni tipicamente da prof, oziose e noiose.
Ok, proviamo allora a considerare i personaggi, almeno per come è possibile ricostruirli tra una pagina e l’altra.
Lui: Robert Kincaid, fotografo giramondo ma anche scrittore-poeta e musicista dilettante. Cinquantadue anni, alto, occhi azzurri, muscoloso ma snello, con piccole natiche inguainate nei jeans. Rigorosamente vegetariano (in compenso fuma come un turco e beve birra, birra, a pintoni). Si autodefinisce l’ultimo cowboy, anzi si ritiene l’ultimo prodotto di un ramo dell’evoluzione condannato a estinguersi (anche se… un po’ di coerenza, diamine, perché altrove si dice che era un essere molto addietro nelle ramificazioni della logica di Darwin. Un babbuino?). Il narratore lo definisce ripetutamente come una specie di stregone, che ospitava dentro di sé luoghi strani, oppure come uno sciamano, caratterizzato da un malinconico senso del tragico combinato a una grande potenza fisica e intellettuale. Ed è proprio il termine “potenza”, declinato in tutte le sue varianti (“potere”, “potente”…), che ritorna ossessivamente nel suo ritratto. Di certo lui si prende tremendamente sul serio, si lancia in pipponi ecologisti e sociologici contro la maledizione dei tempi moderni e crede che sia indispensabile trovare il modo di sublimare gli ormoni maschili, causa ultima dei problemi che affliggono il pianeta. Peccato che nel corso di tutta la storia siano proprio gli ormoni maschili a guidarlo…
Lei: Francesca Johnson, origini italiane (il cognome è quello del marito americano, ed è significativo che non venga mai indicato il cognome da nubile), sposa di guerra. Alta circa uno e sessantacinque, sulla quarantina o poco più, con un viso grazioso e un bel corpo. Capelli lunghi e scuri, sempre trattenuti da un fermaglio. Casalinga, moglie e madre. In realtà si accenna anche a un passato universitario, a una laurea in letteratura comparata e a un’attività come insegnante, abbandonata perché il marito «diceva che era perfettamente in grado di mantenerci e che non c’era alcuna necessità che continuassi». Il narratore-autore-personaggio la fa emergere (o meglio, la fa sprofondare) come una donna che aveva vissuto nell’aspettativa – nella possibilità, perlomeno – di un’esperienza piacevole, che interrompesse finalmente una routine di ossessionante monotonia (Madame Bovary le fa un baffo…). Ma quando lui, dopo quattro giorni di esaltante passione, le propone di abbandonare tutto e di fuggire insieme, lei, pensando a marito e figli, oppone queste ragioni: «Ma più grave e ancora più doloroso sarebbe per lui il dover sopportare per il resto della sua vita i mormorii della gente di qui: […] ne soffrirebbe e i ragazzi diventerebbero l’oggetto degli scherni». Cioè, non è che decide di rinunciare all’amore e alla felicità che lui le offre pensando al dolore che causerebbe e che proverebbe, no, pensa ai mormorii della gente…
Va bene, d’accordo: la complessità dei personaggi non sta tutta e solo in queste poche e arbitrarie notazioni. Io ne ho ricavato comunque un’ipotesi, anzi quasi una certezza: il romanzo è assai probabilmente il racconto, più o meno – appunto – romanzato, di una vicenda reale vissuta dall’autore, Robert James Waller. E cioè: il signor Waller ha conosciuto, in qualche luogo e in qualche tempo, una procace signora, non particolarmente brillante né raffinata ma decisamente disponibile; ha avuto con lei una focosa quanto fugace relazione e ha deciso di trasfigurare tale episodio della propria vita in pagine tanto liricamente costruite quanto poco convincenti, utili ad autoassolversi e, già che c’era, a plasmare un’immagine eroica di sé, delegando tale compito a un fantomatico quanto poco credibile narratore esterno.
Anche la procace ma non brillante né raffinata signora (depilazione e manicure le sono sconosciute) viene in effetti trasfigurata, non solo attraverso l’attribuzione di una laurea in letteratura ma anche attraverso le ripetute sottolineature della sua “intelligenza”: Ma in Francesca Johnson c’era qualcosa che lo colpiva. C’era intelligenza, lo intuiva; e ancora: Studiava il suo corpo, pensava all’intelligenza di cui, ora lo sapeva, era dotata. Già, peccato che tale “intelligenza” non venga fatta emergere mai, ma proprio mai, anzi: Lei non capì e gli chiese spiegazioni; e ancora: Lei non capiva che cosa intendesse. Vero è che lui la sommerge in continuazione di citazioni e riferimenti colti: Rachel Carson, John Muir, Aldo Leopold, Thomas Wolfe… riferimenti che lei ovviamente non conosce e non comprende (per la verità, neppure il lettore…). E mentre lui, durante l’amplesso (gli amplessi, plurale…), le parla delle visioni che proprio lei gli aveva donato… sabbia turbinante e venti color magenta, e pellicani bruni che cavalcavano delfini diretti a nord lungo la costa d’Africa (🙄), lei emette solo piccoli suoni inintelligibili, al massimo bisbiglia Oh, Robert… Robert… E se proprio proprio vuole esprimere qualcosa di “intelligente” dice (o meglio, le viene fatto dire) Robert, sei così potente (e te pareva…). Coerentemente, lui, nell’ultima lettera che le invia parecchi anni dopo il loro incontro, così scrive: cerco di immaginare dove sei e che cosa stai facendo. Niente di complicato… ti vedo in giardino, seduta sulla veranda, in piedi davanti al lavello della cucina. Cioè, non è che se la immagina, che so, mentre legge un libro o scrive qualcosa, no, in piedi davanti al lavello della cucina.
E così, tra sabbia turbinante e venti color magenta, veniamo allo stile del romanzo. Come già detto, la struttura narrativa è molto articolata, ciò che determina una altrettanto articolata varietà stilistica ed espressiva. Se nel capitolo introduttivo e in quelli finali le modalità linguistiche sono assolutamente sobrie e asettiche, nei capitoli centrali la faccenda cambia, e di molto, assumendo i tratti di un lirismo tanto compiaciuto quanto improbabile: Il leopardo infuriava sopra di lei, ancora e ancora, come il vento incessante della prateria, e lei fremeva, travolta dal suo slancio, cavalcava quel vento come una vergine del tempio che avanza verso le fiamme miti e compiacenti che delimitano la dolce curva dell’oblio. Mah…
Di certo, se, mentre faccio l’amore con un uomo, costui mi sussurrasse all’orecchio nel momento culminante «Io sono l’autostrada e il pellegrino e tutte le vele che hanno mai solcato i mari»… bah, forse contatterei il più vicino centro di salute mentale, di sicuro me la filerei a gambe levate.
Comunque, a proposito di stile, consideriamo le figure retoriche, concentrate nei capitoli centrali (e qui ci divertiamo).
Quando lui e lei ballano in cucina (reciprocamente attratti ma non ancora dichiarati), lei avverte l’intensità dell’emozione di lui, acuta come una freccia, in una notte in cui Non c’era vento, e il granturco cresceva (roba che manco Pascoli nel Gelsomino notturno…), mentre, alla luce delle candele, era buio, fatta eccezione per le fiammelle puntate verso l’alto. E quando poi, finalmente, i due danno libero sfogo al reciproco desiderio, la performance di lui è metaforicamente così descritta: Percorse i sentieri delle antiche vie, orientandosi con candele di gelo incendiate dal sole, che si liquefacevano sull’erba estiva (!!!).
Insomma, nonostante il tentativo di presentare come tantrici e trascendenti, quasi mistici, gli amplessi tra i due protagonisti (ciò che esisteva fra loro andava ben oltre l’aspetto fisico. Amarlo era spirituale, spirituale), l’attenzione del narratore-autore, conscia o inconscia, è tutta concentrata lì, sempre e soltanto lì.
D’altra parte, tutto ma proprio tutto il romanzo è ossessivamente disseminato di immagini e oggetti dal chiaro simbolismo sessuale: lance, frecce, missili, candele, coltelli, treni che si inerpicano… Insomma, tutto il più scontato repertorio onirico freudiano.
E non mi si venga a dire che me ne sono accorta solo perché sono una donna, secondo la ridicola storia dell’ “invidia del pene”…
Anzi, già che siamo in territorio freudiano, non poteva mancare il più classico dei classici: un bel complesso di Edipo! Nel libro vi si accenna velatamente nel penultimo capitolo (il film, al contrario, coglie e amplifica di molto il tema), nell’imbarazzo del figlio, Michael, che prende atto dei ricordi della madre, la quale madre non solo non si risparmia nei particolari circa la propria relazione extraconiugale ma anzi specifica che non credo che sia possibile trovare in un uomo il particolare potere di cui Robert Kincaid era dotato. Questo ti mette fuori gioco, Michael.
No comment 😔.
Ma non è questo, non è questo, non è questo quello che più mi ha disturbato nella lettura del libro. Quello che più mi ha contrariata, e indispettita, e urtata, e irritata, e profondamente indignata, è la visione esclusivamente maschile, anzi, biecamente maschilista del rapporto uomo-donna. Una visione predatoria e ferina, in cui lui si avvicina a lei come farebbe un leopardo nell’erba alta della savana. Una visione in cui lui non fa semplicemente l’amore ma “affonda”, “sprofonda”, “cavalca”, “domina”, “infuria”. Una visione in cui lui, tentando di sottrarsi al fascino di lei, si esorta a pensare a un’altra donna, assai compiacente: e al tramonto ascoltala urlare mentre la penetri (sinceramente, non si capisce perché una donna, in quel momento, debba “urlare”. A meno che non sia vittima di uno stupro...). Una visione in cui, infine, è presente una rappresentazione stereotipata, distorta e, appunto, biecamente maschilista della psicologia femminile: lui la dominava completamente, proprio come lei desiderava che accadesse.
In conclusione…
Se consiglio il libro? Oh sì, certo: lo consiglio a tutti quegli uomini che si gingillano e si crogiolano nella propria delirante illusione di potenza, i quali uomini si identificheranno immediatamente nella tanto autocompiaciuta quanto fittizia complessità interiore del protagonista e soprattutto nella sua sostanziale e radicatissima ferinità; sono certa che apprezzeranno molto la lettura.
Soprattutto, consiglio il libro a tutte quelle donne che non rinunciano a esercitare la propria capacità critica, a difendere e ad amare la propria dignità, a rifiutare di essere rappresentate secondo cliché umilianti, a riconoscere e combattere mentalità tanto rivoltanti quanto pericolose, le quali donne non si identificheranno affatto nella supinità della protagonista, nel suo essere acquiescente ed eternamente subordinata al maschio, nel suo essere complice di stereotipi triti e ritriti, nel suo rinunciare alla propria felicità (e non per la felicità altrui, il che sarebbe comprensibile e finanche ammirevole, ma solo per meschini scrupoli piccolo-borghesi). Ecco, a tutte queste donne consiglio - provocatoriamente - questo libro: sono certa che lo odieranno.
Amen.